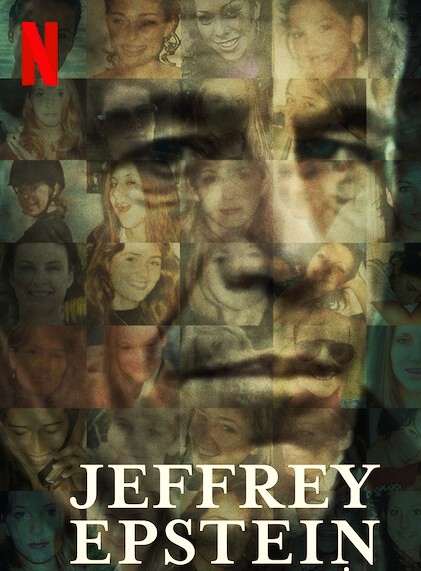In questi giorni ho scritto alcuni post sull’argomento, mettendo nero su bianco la sensazione di nausea che prende quando si osserva questo meccanismo: le grandi opere che diventano palcoscenico, i lavoratori lasciati a secco, le piccole imprese che attendono invano i pagamenti.
Ed ecco che, puntuale come la cronaca, è arrivata la scena successiva.
Anthony Barbagallo denuncia lo stallo sul “lotto 3” della Ragusa-Catania. Operai in sciopero. Stipendi non pagati da novembre. Un’opera strategica, già finanziata, appaltata, di nuovo ferma.
Come avevo scritto, quanto accade non è un caso, non si tratta di una disgrazia occasionale: questo rappresenta – ormai da anni – il sistema che produce esattamente il risultato per cui è stato progettato.
Barbagallo parla del “codice degli appalti voluto da Salvini” e dei “subappalti a catena”. Io, viceversa, osservo da anni il risultato finale di quelle catene: chi sta all’ultimo anello viene semplicemente staccato e lasciato cadere!
Nel mio precedente post parlavo di “General contractor” che si aggiudicano gli appalti, avviano i cantieri, e poi, alla prima difficoltà, dichiarano crisi o, peggio ancora, passano il testimone in un gioco di scatole cinesi, solitamente ad altre imprese che hanno già dimostrato di presentare gli stessi problemi.
Ecco perché Barbagallo oggi chiede che le imprese sostituite lo siano solo tramite nuovo bando pubblico.
Perché è esattamente questo il punto. Perché oggi, in Italia, si può perdere una gara, essere inefficienti, e rimanere comunque dentro al sistema. Si cambia ragione sociale, si affitta un ramo d’azienda, si lascia il cerino acceso in mano ai creditori e ci si ripresenta alla prossima asta.
E chi paga? I lavoratori, che da novembre vivono di ansia e non di stipendio; le imprese locali, che hanno fornito inerti, cls, bitume, e che ora rischiano di fallire per un credito mai saldato.
Ma non solo: paga anche il territorio, sì… perché aspetta un’infrastruttura vitale e si ritrova, come sempre, con un cartello “cantiere sospeso” e le solite, abituali polemiche della politica.
Il segretario del Pd chiede un tavolo tecnico. Ritengo sia giusto, è doveroso. Ma io mi chiedo: quanti tavoli tecnici servono ancora prima di capire che il problema non è la mancanza di un confronto, ma l’assenza di responsabilità?
Allora mi viene spontaneo chiedere: se, come sempre accade, si procederà con il solito tavolo tecnico, che differenza c’è tra rispettare il contratto e non rispettarlo?
La sensazione, amara e persistente, è che la Sicilia venga utilizzata come una “landa di frontiera” del capitalismo italiano. Il posto dove si sperimentano i modelli finanziari più spregiudicati, dove i costi sociali si scaricano a valle, dove le regole si allentano perché tanto, alla fine, “c’è sempre qualcuno che protesta, ma nessuno che ferma davvero i cantieri”.
E invece i cantieri vanno fermati. Non i lavori: i cantieri fasulli!
Quelli dove si piantano le bandierine per incassare i primi stati di avanzamento e poi si abbandona tutto; quelli dove il cantiere è aperto giusto il tempo di far maturare i crediti verso lo Stato, che poi verranno ceduti, scontati, smaterializzati in operazioni finanziarie che non hanno più nulla a che fare con l’asfalto e il cemento.
La Ragusa-Catania non è solo un’opera. È un simbolo! E non do la colpa a questo attuale governo, ma a tutti quelli che per trent’anni si sono succeduti, prendendo migliaia e migliaia di preferenze, per stare seduti in quelle poltrone di Roma, senza fare mai un caz…
È il termometro di quanto questo Paese sia stato disposto a tollerare. E cioè: che il Sud è stato trattato come una succursale, sì… una periferia sacrificabile!
Barbagallo parla di “frutto amaro” e “indigesto”. Ha ragione. Ma attenzione… non è il sapore amaro di un frutto acerbo: è il sapore di un frutto marcio. E la putrefazione, si sa, parte sempre dall’interno!
O si interviene sul meccanismo – garanzie reali, responsabilità solidale a cascata, niente subentri senza trasparenza – oppure continuerò a dover scrivere lo stesso post tra due anni, su un altro lotto, con altri operai sotto il sole a brandire cartelli e con gli stessi mesi di stipendio non pagati.
Io quel post l’ho scritto, riscritto e scritto nuovamente. Oggi – ahimè – lo integro con la cronaca.
Ma ripeto: è una cronaca che conosciamo a memoria. E non credo sia più sopportabile.